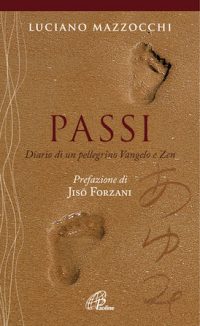In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero».
* La danza dei semplici
Quello di questa domenica è detto da alcuni il passo del Vangelo più soave. È l asoavità che scaturisce dalla vita vissuta in modo severo ed impegnato, senza cedere all’indolenza né alla presunzione. È la soavità di un frutto che è maturo sull’albero, sopportando tutto il sole, tutta la pioggia, tutti i venti, tutti gli sbalzi di temperatura dal giorno alla notte. È la soavità maturata nel rigore dell’autenticità. Quando Gesù pronunciò il Vangelo di oggi, la sua persona era attraversata da un fremito di commozione e di esultanza, suscitato dalla sua esperienza personale e dagli avvenimenti di quei giorni. L’avvenimento decisivo che lo fece esultare fu senz’altro il ritorno gioioso dei suoi discepoli dal primo viaggio missionario a cui lui stesso li aveva mandati. Erano partiti titubanti, perché senza titolo di studio, senza una posizione sociale di riguardo; anzi portando con se tutti i loro difetti e limiti. I dotti scribi e farisei li avrebbero senz’altro derisi. Andarono e portarono buoni frutti: la gente li aveva accolti e ascoltati. Per Gesù ciò era la prova che sono proprio i piccoli a essere benedetti. Sono loro che seminano nel mondo la speranza. Sono loro i grandi. Allora si mise a danzare dalla gioia, come un giorno danzeranno Francesco d’Assisi e tanti altri piccoli. Un uomo maturo che danzi è abbastanza strano per i sapienti.
«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ai rivelate ai piccoli». Gesù sa di essere uno dei piccoli e da sua madre aveva senz’altro ascoltato il discorso dei suoi umili natali. Gesù si sente piccolo, perché vive aderente alla vita, non straripando nelle illusioni che gonfiano e fanno sentire grandi. Aderisce al limite della sua vocazione che è quello di una vita breve e dentro i confini del minuscolo stato di Israele, ormai privato della sua indipendenza. A chi gli chiedeva di far da giudice tra lui e suo fratello, risponde che quanto gli veniva chiesto esulava dal limite della sua vocazione. Soprattutto si sente piccolo della sua vocazione. Soprattutto si sente piccolo all’ultima cena prima di morire. È consapevole che non può più dare altro ai suoi discepoli, se non partire da loro e far ritorno al Padre. Ora la sua vocazione è quella di andare nella terra come il seme di frumento, e scomparire. Solo così gli apostoli possono crescere liberi nello spirito.
Gesù aveva mandato i suoi discepoli in missione due a due. Due a due è un altro modo di essere piccoli, perché esige di lasciare spazio all’altro. Non esiste piccolezza autentica se non condividendo il cammino della vita con altri diversi da me e che io non ho scelto.senza la vita comunitaria l’uomo non ritorna a essere piccolo; anche se parla molto di umiltà e di piccolezza, quel parlarne è artefatto. Non esiste piccolezza autentica se non condividendo il cammino della vita con altri diversi da me e che io non ho scelto. Senza la vita comunitaria l’uomo non ritorna a essere piccolo; anche se porla molto di umiltà e di piccolezza, quel parlarne è artefatto. Non c’è piccolezza finche l’altro non mi impone di farmi piccolo e io lo accetti, non tanto da illuminato, ma piuttosto brontolando. L’umiltà illuminata, nella quale io sono consapevole di essere umile a differenza degli altri che sono prepotenti, è umiltà vanitosa e orgogliosa. L’umiltà vera è quella che nemmeno suscita la consapevolezza di essere umili. Infatti un piccolo che si autocompiace di essere piccolo, è gonfio di piccolezza, ma sempre gonfio. «Due a due»: la vita matrimoniale è senz’altro una via eccellente alla piccolezza; i suoi frutti più squisiti sono i bambini.
«Nessuno conosce il Figlio, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare». Com’è piccolo il sentiero della fede! Tanto piccolo che non si può dire: è questo; è quello! Nessuno conosce il Padre se non il Figlio; ma altrettanto nessuno conosce il figlio se non il Padre! Allora da dove si può conoscere? È vano il nostro cercare Dio come se lo conquistassimo dall’esterno. Infatti già, anzi da sempre, noi siamo nelle mani del Padre e nel cuore del Cristo. Se l’incontro con Dio fosse il risultato di un assalto esigerebbe persone grandi e agguerrite. Invece, è detto nel salmo, «Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre in silenzio nemici e ribelli» (Sal 8,3). I lattanti sono i sacerdoti dell’Onnipotente; i loro vagiti sono le sue epopee. Dio è piccolo, è mite e umile di cuore! Dio è estremamente semplice! Infatti nessuno lo comprende e lo sa indicare come il bambino. Ma allora perché nasciamo piccoli per diventare grandi, e non viceversa? Perché dobbiamo sbagliare tanto, prima di comprendere e convertirci?
Forse perché anche Dio è piccolo e ama giocare! Quando uno, crescendo, ha raggiunto tutta la scienza possibile e ha compiuto imprese grandi, e poi prega con il cuore di un bambino, allora è veramente piccolo! Un grande piccolo, come è piccolo il grande Iddio!
* Non sapere
Nel buddismo non si parla solitamente di peccato. Credo sia molto difficile per un buddista orientale comprendere cosa significhi peccato originale, servendosi delle categorie espressive che ci sono famigliari in occidente. Certo, anche per noi che ci sentiamo ripetere da sempre questa espressione, è tutt’altro che facile comprenderne il senso profondo. Certo, anche nel pensiero orientale esiste l’idea del male, della colpa, della responsabilità, ma, forse a causa della non centralità del concetto di persona, l’idea di peccato non ha assolutamente il risalto che ha nella nostra sensibilità religiosa. Non credo di aver mai trovato la parola peccato in un testo buddista orientale, se non in quelli moderni che la usano più che altro nella speranza di farsi capire dagli occidentali.
Nel buddismo si parla invece, molto, di ignoranza. Non dico che ignoranza sia, in linguaggio buddista, l’equivalente di ciò che rappresenta peccato nel linguaggio cristiano. Voglio però dire che, se la molla che spinge il cristiano a ispirare la sua vita al Vangelo è la consapevolezza del peccato, sul versante buddista la molla che instrada alla Via è la consapevolezza dell’ignoranza. Senza cadere in facili quanto inconcludenti schematizzazioni, è innegabile che nel buddismo si sostiene che l’ignoranza è la causa prima dello stato del mondo. Anzi, se consideriamo la dottrina buddista, nella teoria delle dodici cause concomitanti del prodursi interdipendente di tutti i fenomeni, (Juni innen) che è la spiegazione della realtà, la prima causa del ciclo è proprio l’ignoranza (mumyo). Mumyo vuol dire non luminoso, non chiaro, non rischiarato; in linguaggio biblico, che è più incline al dramma e al sentimento, forse si direbbe tenebra. Comunque, l’ignoranza intesa come oscurità, non chiarezza, è ciò che innesca il meccanismo di quella catena che è, contemporaneamente, la trama della realtà e la serie di anelli che ci imprigiona.
Allora, sarà la conoscenza il rimedio da cercare? Sarà il sapiente, l’intelligente colui che può trovare riparo dal male, e l’ignorante, lo stolto colui che soccombe? Se è così, siamo in aperta contraddizione con il Vangelo che dice «Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli».
Un famoso dialogo la cui eco ci giunge dall’antica Cina, così riferisce: Il maestro Rakan Keishin (867-928) chiese un giorno al monaco Hogen Buneki: «Che cosa è l’essenza dello Zen?». Hogen rispose: «Non so». Rakan disse: «Non sapere, ecco q1uanto vi è di più veritiero!».
Un’altra espressione famigliare allo Zen dice: «La mucca e il tasso sanno, i Budda e i patriarchi non sanno». Non sapere, ecco il vero modo di andare al di là dell’ignoranza. Siamo nel cuore della contraddizione. Eppure così funziona la realtà originaria. C’è una sapienza che passa attraverso il non sapere perché è un essere. Come quando sono in mezzo al mare e debbo nuotare con tutte le forze: non so più la tecnica del nuoto, c’è un tutt’uno che è io-il mare-il nuoto. Questo è il sapere della mucca e del tasso e il non sapere dei Budda e dei patriarchi. Questo è essere piccoli e queste cose ai piccoli sono rivelate. Piccoli perché dimentichi di sé. Ciò non significa che la conoscenza e l’intelligenza siano da disprezzare: anzi, sono beni preziosi, che dobbiamo coltivare con cura: se non uso tutta l’intelligenza che la natura mi ha elargito, se non sondo le capacità di conoscenza che sono alla portata del mio talento intellettivo, non sarò mai davvero piccolo nel senso evangelico. Ma dice piccolo anziché grande, dice non sapere anziché sapere per farci intendere che, giunti ai limiti delle nostre facoltà, dobbiamo fare un salto di abbandono. Conoscere se stessi è dimenticare se stessi: è nella perdita che si rivela il vero volto della vita, il vero volto del sé.
Per andare oltre l’ignoranza è necessario passare attraverso di essa, attraverso quell’oscurità, quella tenebra da cui scaturisce il reale. I grandi mistici ci parlano tutti del buio, come della frontiera da attraversare. Il buio si ritrae di fronte alla luce e nello stesso tempo la glorifica. L’abbraccio che tutti abbraccia accoglie la luce e il buio, la sapienza che tutto sa sperimenta l’ignoranza e la conoscenza.
Padre Luciano Mazzocchi
Nessun tag per questo post.