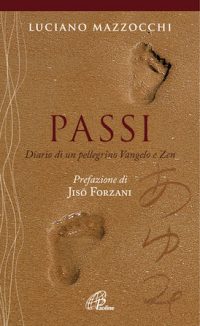In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbì” dalla gente.
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato»
- L’ipocrisia e l’ira del Vangelo
Il Vangelo di questa domenica è un forte messaggio per al purificazione di ogni comportamento farisaico e ipocrita dell’uomo. Dobbiamo ascoltarlo con l’umiltà fondata sulla conoscenza realistica di se stesso: fariseo è ciascuno di noi. Se ascoltassimo questo Vangelo per puntare il dito verso gli altri, ciò sarebbe il segno evidente della nostra ipocrisia. Il Vangelo è rivolto a ciascuno, perché in ciascuno lottano sincerità di cuore e tendenza all’ipocrisia.
«Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno». Il Vangelo proclama una serie di «guai a voi!» rivolti ai farisei e a tutti coloro che si comportano in modo ipocrita, facendo uso del nome i Dio. La misericordia di Dio esplode in ira, perché l’ira è l’unica misericordia in questi casi. Anche se l’uomo cade nell’ipocrisia, Dio rimane sincero e chiama con il proprio nome ogni cosa, lui che ne conosce l’origine autentica e quindi soffre per ogni manomissione operata dall’uomo. L’ipocrisia manda in escandescenza il Dio segreto e nascosto che abbraccia nella sua calma interiore tutte le esistenze, compresi gli astri del cielo. L’ipocrisia mette sotto sopra la calma del cielo.
L’ipocrisia attecchisce negli ambienti religiosi, soprattutto nel cuore dei ministri della religione. Allora religione chiama ricchezza. L’ipocrisia è come la tenia che si è annidata nell’intestino dell’uomo: la si espelle, ma ne rimane sempre l’estrema punta capace di riprodursi in pochi giorni, finché non viene espulsa con una cura veramente drastica. L’ipocrisia genera quella furbizia, per cui si immunizza contro la lotta che le viene ingaggiata. Si può rimanere fondamentalmente nell’ipocrisia grazie al fatto che ci si copre di anatemi contro gli ipocriti; oppure, al contrario coprendosi sotto le benemerenze della misericordia di Dio. A volte si tira in ballo l’autorità o la tradizione a proprio favore; a volte, come disse Gesù, si ergono monumenti ai profeti uccisi dagli antenati e, coperti da tale parvenza di integrità critica, si continua a uccidere i profeti del presente. Anche la Chiesa è pronta a riconoscere gli errori dell’inquisizione dei secoli passati, ma le è difficile ammettere l’autoritarismo del presente.
Dio è «Io sono colui che sono» (Es 3,14): questo è il suo nome. La verità è essere ciò che si è; l’ipocrisia è fingere di essere, senza essere. L’ira di Dio verso la nostra ipocrisia scaturisce dalla sua gelosia di Creatore che ci vuole realmente veri e non fintamente veri. L’ira di Dio contro la nostra ipocrisia è l’ultima nostra ancora di salvezza: egli non ci da pace finché non ci togliamo le maschere. Tutto può compromettersi col nostro compromesso; ma Dio no. Nessuno lo ha mai imbrogliato con titoli o parvenze: egli vede il cuore.
La religiosità che fuoriesce dall’ipocrisia è il moralismo: ci si erge a giudici severi sugli altri senza muovere un dito per aiutarli. Quasi le difficoltà degli altri ci facessero piacere, perché ci danno la possibilità di mettere all’opera la nostra critica severa. «Legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito». Il moralismo delle religioni ha impedito la crescita di molte persone, imponendo delle norme morali senza prima aver aiutato l’individuo a crescere al punto di poter mettere in pratica quelle norme con gioiosa convinzione personale. La consuetudine del battesimo conferito in età infantile produce quel cristianesimo di tradizione e senza convinzione personale che è l’ambiente adatto per il moralismo. La via opposta al moralismo, quindi all’ipocrisia, scorre tra due sponde: la prima è la sincerità del cuore che vuole veramente il bene; la seconda è il discernimento coraggioso che aiuta a scegliere quel comportamento concreto che veramente mette in atto la sincerità del cuore. La Chiesa può compiere la campagna contro l’aborto facendo leva sulla paura del castigo; oppure, al contrario, promuovendo l’ambiente in cui ogni bambino che deve nascere possa essere accolto e amato. La sincerità del cuore è radicata nel rispetto della vita; il coraggioso discernimento consiste nel promuovere quel vivere sociale sobrio e sereno in cui i bambini possano nascere e crescere.
Ci sono nella Chiesa esempi di pastori autentici, incuranti di tutto ciò che è tornaconto personale e dediti a promuovere l’ambiente in cui ciascuno possa crescere secondo la sua natura e vocazione. Ne rendiamo grazie!
«Voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è i Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo». Che dire, davanti a queste parole di Gesù, della consuetudine di noi missionari nel farci chiamare “padre”? Perché tanti titoli onorifici: “santità”, “eminenza”, “eccellenza”, per coloro che sono ministri dell’unico “Maestro”? Che forse Cristo non diceva sul serio? Oppure che noi non ascoltiamo sul serio? Si potrebbe commentare che non vale la pena far questione di cosette come i titoli. Rileggiamo il Vangelo con attenzione e comprendiamo. Le montagne sono fatte di granelli di polvere.
Chi confida nella sua forza e dimentica la sua debolezza cade. Chi teme la sua debolezza e non conosce la sua forza non si risolleva mai. «Chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato».
- Mal d’orecchie
C’è un’espressione di uso comune in giapponese che, tradotte, suona: «Mi fan male le orecchie». Si usa quando qualcuno descrive un difetto, un atteggiamento, un modo di fare improprio e noi ci sentiamo chiamati in causa, come se stessero proprio parlando di noi, anche se chi parla non ha minimamente quell’intenzione. Allora si dice «mi fanno male le orecchie», per dire che l’eco di quelle parole fa male perché mi hanno colpito. Credo che la stragrande parte dei religiosi che hanno ruoli di guida, cristiani o buddisti che siano, dovrebbero sentire un acuto mal d’orecchie alla lettura di questo brano del Vangelo. È uno di quei casi in cui facciamo deliberatamente il contrario di ciò che sappiamo di dover fare, e di buon grado ci facciamo chiamare sia padri che maestri. Lascio ai religiosi cristiani l’esame di coscienza che a loro compete. Come buddista devo sire che questo brano del Vangelo mi fa venire un po’ di male d’orecchie.
Infatti, anche se un buddista potrebbe dire che quelle parole non sono scritte per lui, in realtà non è così: l’appellativo di maestro, così frequente nel buddismo occidentale, è, proprio da un punto di vista buddista, un’usurpazione, eppure è rarissimo trovare un buddista nostrano che non si ecciti (almeno interiormente) all’idea di fregiarsi prima o poi di quel titolo. Io ho usato spesso, in questi commenti, l’espressione maestro-discepolo, che è invalsa nell’uso: questa è l’occasione per specificare cosa si intende dire con quell’espressione e in quale accezione sia usato il termine maestro, che in realtà è inesatto e fuorviante. Premetto che parlo di questo argomento sulla base di un rapporto di quindici anni con il mio maestro, dodici dei quali trascorsi quotidianamente insieme: rapporto prezioso, del cui valore mai sarò appieno consapevole.
Il solo maestro che ci sia nel buddismo è la Via indicata dal Budda. Egli stesso mise in guardia da considerare lui, come individuo, il maestro, figurarci se possiamo noi considerarci maestri. Se per maestro si intende uno che ha maestria, che padroneggia l’arte di seguire la Via, ebbene tale figura non esiste, perché seguire la Via non è un’arte e non può mai essere padroneggiata. Della Via siamo tutti discepoli, volta a volta con ruoli diversi, ma tutti in ascolto obbediente: non ci deve essere nessuno che parla soltanto e non ascolta più. Se per maestro si intende uno che insegna la via, ebbene anche in questo caso un ruolo fisso del genere non esiste, perché la Via non si insegna e non si impara. Sulla Via siamo tutti viandanti, la Via si percorre e si vive, si seguono certo indicazioni e anche ordini, ma il percorso è sempre e solo quello delle mie gambe: e non c’è chi sta fermo o cammina al posto di un altro. Né si può andare in groppa. Se per maestro si intende invece qualcuno a cui si domanda per avere indicazioni, allora è infinito il numero di maestri. E non sono solo esseri umani di carne e ossa. Nel buddismo si dice che bisogna chiedere a tutto, e da ogni cosa lasciarsi dire quello che ci ha da dire. Doghen dice: «Domanda allo scettro e allo scacciamosche, interroga la lanterna e il pilastro!» (Shoboghenzo Dotoku – Saper esprimere la Via). Budda ha testimoniato: «Tutto, esseri inanimati e inanimati, montagne, fiumi, erba e alberi, raggiunge in questo istante la Via perfetta»: tutto non fa che esprimere la Via: ogni cosa è maestro e ogni maestro è in ascolto. Zazen è l’unico maestro, e durante zazen il muro è maestro, così come il corpo, il flusso dei pensieri, i rumori della strada: chi cerca un maestro speciale, chi si propone come speciale maestro umilia la Via del Budda.
Se poi per maestro si intende la persona cui facciamo riferimento per camminare assieme, di cui ci fidiamo perché ha a cuore il cammino, il suo come il nostro, e non il suo prestigio o la sua posizione, a cui obbediamo perché la sappiamo obbediente, allora quel rapporto è prezioso, ma inadeguato è il termine maestro.
Nel commento della terza domenica di avvento, in cui anche è trattato questo tema, ho citato un passo di Doghen che qui riporto nuovamente:
Nessun tag per questo post.«A partire dal fondatore del buddismo, Sakyamuni, tutti coloro che hanno vissuto vedendo chiaramente il giusto modo di esistere, mentre hanno continuato a trasmettere da una persona che aveva realmente quel carattere a un’altra che a sua volta lo possedeva, hanno testimoniato quel modo di vivere perfettamente armonioso. Non vi è che un modo supremo al di là delle possibilità della nostra volontà, che è base e fondamento di quel modo di essere. Questo modo è come versare tutta l’acqua di un recipiente così come è in un altro.
Ciò che è così trasmesso è l’individualità che vie il Sé originale in forma autentica; proprio questo modo di vivere è la base, la norma caratteristica dell’insegnamento di Sakyamuni» (Il cammino religioso – Bendōwa).
Non mi pare possano sussistere dubbi su quale sia la natura di questo rapporto da persona viva a persona viva.
I «maestri» antichi avevano ben chiaro il rischio di fraintendimento che può ingenerare parlare di maestri. Sentiamo il consiglio di Ekai Mumon (1183-1260)
Incontrando un maestro di Zen lungo la strada
non affrontatelo né con le parole né con il silenzio.
Tirategli un pugno in faccia,
e vi diranno che capite lo Zen.