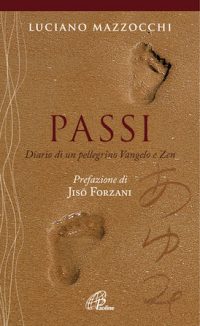Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: “Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un`asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito”. Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: Dite alla figlia di Sion:
Ecco, il tuo re viene a te
mite, seduto su un`asina,
con un puledro figlio di bestia da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l`asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava:Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: “Chi è costui?”. E la folla rispondeva: “Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea”.
* La via della croce
Il Vangelo della passione del Signore occupa uno spazio molto rilevante nel testo evangelico. Questo denota come fosse centrale e decisivo nella fede dei primi discepoli l’avvenimento della passione e morte del Signore. Le pagine dedicate alla risurrezione sono invece più sobrie; nel Vangelo secondo Marco la risurrezione e soltanto abbozzata come un accenno finale. Questo, che per noi risulta come una carenza, per lo Spirito che ha suscitato i Vangeli è invece il modo più proprio per annunciare la liberazione attraverso Cristo. Infatti ci indica la via: è portando la croce che si attua la risurrezione.
Cristo entra in quella Gerusalemme che sarà l’altare della sua passione, accogliendo l’osanna che il popolo gli tributa sventolando i rami di palma. Entrava da vincitore nello spazio, la città di Gerusalemme, e nel tempo, la settimana della Pasqua ebraica, in cui era chiamato a soffrire e a morire! L’attendeva la prova del tradimento del discepolo, della condanna dei sommi sacerdoti, della crocifissione fuori le mura di Gerusalemme, come un malfattore pubblico. Mentre attendeva era già vincitore, perché in lui era già piena l’adesione alla volontà del Padre; piena al punto di essere gloriosa! “E’ giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo… Per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo glorifichero“. (Gv 12,23-28). La sofferenza altro non è che il dolore del parto di ogni convinzione profonda che freme per realizzarsi nella storia. Quando nel cuore dell’uomo freme una convinzione forte, soffrire è la via da percorre con riconoscenza e gloria.
“E quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: “Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E’ il re d ‘Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti Sono Figlio di Dio!”.
I passanti non riuscivano a sintonizzarsi con la potente onda della carità presente nel cuore di Cristo. Non comprendevano affatto ciò che stava accadendo. Per loro Cristo era un re fallito, un Figlio di Dio fallito, oppure il figlio di un Dio fallito. Così pensavano e, pensando cosi, semplicemente ragionavano secondo il buon senso che dà per scontato che Dio, per sua natura, non conosca il dolore ma solo la pienezza della gioia; mentre l’uomo, per sua natura, e sottoposto all’errore e alla sofferenza. In altre parole, per noi Dio e quell’essere fortunato che noi vorremmo essere, ma che il destino di nascere uomini ci ha impedito di essere. E’ quindi la proiezione della nostra frustrazione esistenziale. Verso la felicita di un tale Dio noi nutriamo invidia che manifestiamo come adorazione se siamo pii, oppure come bestemmia se siamo empi. Sotto la croce di Cristo, i sommi sacerdoti del tempio di Gerusalemme, rappresentanti di tutte le teologie umane, bestemmiavano Cristo e lo deridevano, perché non corrispondeva alle loro immaginazioni su Dio. All’uomo piace più il Dio della propria immaginazione che il Dio reale. Il Dio della nostra immaginazione non esige che ci convertiamo: infatti combacia con i nostri attaccamenti.
“Io sono colui che sono” (Es 3,14). Dio abita nell’essere e non nelle nostre immaginazioni, né nelle fortunose condizioni in cui vorremmo che abitasse. L’uomo incontra Dio, non percorrendo i sentieri dei suoi desideri e dei suoi attaccamenti, come se Dio fosse la loro sublimazione; ma quando molla tutto e si libra nel vuoto. Allora Dio è Dio, non è prefigurato o modellato da alcuno. Dio che è Dio porta la croce e muore sopra di essa, sospeso tra cielo e terra. Dio che è Dio percorre l’unica via che anche noi percorriamo: tutto ciò che è dell’uomo è pure di Dio e lo è da Dio, non come proiezione della nostra mente. Infatti Dio è reale e abita nella realtà; non e una prefigurazione.
Dio soffre e soffre da Dio: non perché vittima di altri, non per brama di miglioramento, non per salvare gli uomini. Non sono gli uomini a far soffrire Dio; sono invece la sua perfezione e il suo amore. Soffre, perché egli è l’origine di tutte le esistenze, le quali soffrono. Dio soffre da Dio: ossia la sua sofferenza è purissima, in profonda comunione con la gioia. Gioia e dolore si alimentano a vicenda. Dio soffre da Dio e la sua croce porta frutti generosi per la liberazione di tutti e di tutto. Non è una sofferenza funzionale; ma pienamente libera. Infatti il nostro peccato, occasione della croce di Dio, a sua volta esiste soltanto perché Dio lo permette. Dalla libertà di Dio ha origine sia il peccato dell’uomo, sia la croce di Cristo che lo redime. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine (Eb 2,11).
E’ la natura stessa di Dio che richiede a Dio di soffire: è l’amore. Così la sua sofferenza è gloriosa, di natura divina. Gli antichi ebrei morsicati nel deserto dai serpenti velenosi fissavano il serpente di bronzo issato su un palo per essere salvi. Cristo afferma: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io sono” (Gv 8,27). E’ sulla croce che il Figlio si manifesta come Figlio. Maria in piedi e dignitosa partecipava del dolore e della speranza che è nel cuore di Cristo. Guardava in faccia al dolore senza filtri consolatori, entrando nella fede della risurrezione. In Maria nasceva la Chiesa.
p.Luciano

* Il fiume che scorre nel fiume
Il seguente commento si riferisce al brano di Vangelo che narra l’entrata di Gesù in Gerusalemme (Mt. 21,1-11) episodio pieno di allegria e levità: poi gli eventi si andranno man mano incupendo, fino alla morte di Gesù alla parte più propriamente di Passione si riferiscono i commenti 1 e 3.
Leggiamo oggi come Gesù abbia fatto il suo ingresso in Gerusalemme, il suo ingresso regale e messianico, seduto su di un’asina. Questo particolare ci e di grande aiuto. Gesù e uno che va per la sua strada, che cammina con le proprie gambe per un sentiero dove nessuno ha mai camminato prima, che va avanti da solo fino alle estreme conseguenze, come dimostrerà negli eventi successivi della passione e della morte. Eppure oggi si fa portare da un’asina: e non per fare una bella scenetta, o per entrare più dignitosamente che non a piedi: ma perché ne ha bisogno, come fa dire ai suoi discepoli. “Il signore ne ha bisogno“. Che cos’è quest’asina di cui persino il Signore ha bisogno?
“Questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato“. In tanti momenti salienti del Vangelo, noi troviamo il richiamo alle Scritture, alla tradizione, a ciò che già e stato detto e predetto. Proprio nei momenti che sembrano più innovativi e rivoluzionari, una citazione ci ricorda che l’opera di Gesù è adempimento, non invenzione, e che la farina che dispensa non è del suo sacco. L’asina che Gesù cavalca e la via dei profeti che l’hanno preceduto, la tradizione che lo trasporta. Certo, cavalcandola la rende viva e la rinnova: certo, la rimanderà subito, per non addormentarsi facendosi portare dall’andatura dondolante, per non diventare un intontito professionista della tradizione. Pero questi punti di riferimento sono importanti come i cartelli stradali che ogni tanto indicano che si è sulla via giusta, e non si segue invece la mappa delle proprie fantasie. Persino Gesu ne ha bisogno, lo riconosce e lo afferma con estrema chiarezza: quanto piu noi, oggi, che siamo tentati di vedere la tradizione o come lettera morta o come comodo veicolo su cui addormentarci.
Anche nello Zen il richiamo e ii riferimento alla tradizione viva di importanza fondamentale. Studiare i detti degli antichi maestri – Seguire la via dei budda e dei patriarchi – sono espressioni assolutamente non marginali: ii fiume che e la mia vita scorre inseparabile dai fiume della vita e non sono lo che ne invento la direzione. La via e la direzione in cui scorre la vita: la mia come quella di chi mi ha preceduto e di chi verrà. Sapere che c’è un’asina legata che mi aspetta in quel punto, vuol dire sapere di aver seguito la direzione giusta. Comprendere i detti degli antichi maestri vuol dire capire il segno che ha lasciato chi e passato di qui, sul sentiero che io solo percorro a modo mio ma che, in quanto sentiero, è non mio. Quasi tutti gli scritti di Doghen iniziano con una citazione di più antiche scritture. Egli poi le ridice a suo modo, le legge e le pronuncia in modo inconfondibile con la sua propria voce. Così facendo le rinnova e le riporta al valore vivo di quando furono dette. E’ significativo che quanto più grande e un maestro o un uomo di spirito, di qualunque religione o tradizione di pensiero, tanto più ha cura di mostrare il suo collegamento senza fratture alla via dei predecessori. Questo vale per i religiosi, per gli scienziati, per gli artisti, per i filosofi, per tutti coloro che cercano di utilizzare la propria vita e le proprie facoltà per dire qualcosa di universale sulla vita. Trovare l’asina legata nel villaggio che ci sta dl fronte, e tutta qui la sicurezza della persona della via. E come un deja-vu che ci garantisce che, anche se ci stiamo addentrando in territori che ci sono sconosciuti, la direzione del fiume segue il corso di sempre e noi non siamo poi così soli come a volte abbiamo l’orgoglio di pensare.
Jiso

* I due piatti della bilancia
La saggezza, così come la si intende comunemente, è la capacità di mediare, di smussare gli angoli non rinunciando tuttavia al proprio modo di vedere e di pensare. Chi è saggio guida gli eventi in direzione di quella che ritiene essere la soluzione migliore evitando di pensare in modo esclusivo al proprio vantaggio e appianando i contrasti.
Il politico, se saggio e attento al bene comune, è un bene prezioso per lo stato. Basta però che uno di questi due aspetti – saggezza, attenzione al bene comune – venga meno perché il politico diventi un pericolo: se infatti, al di là di quanto appare, mira al proprio vantaggio personale, quella che potrebbe essere scambiata per saggezza è in realtà astuzia e questa si serve naturalmente dell’imbroglio: pensiamo al classico esempio del cavallo di Troia con il quale i greci si sono assicurati la vittoria facendo intendere ai troiani che si trattava di un dono. Se mira al bene comune, ma non e in grado di mediare, rischia di essere frainteso, criticato, e quindi messo nell’impossibilita di operare. La saggezza dunque, che è prudenza, compostezza, intelligenza, lungimiranza, è una dote apprezzabilissima.
Se leggiamo gli avvenimenti riguardanti la vita di Gesù avendo presente in modo particolare la conclusione della sua esistenza, sicuramente dobbiamo ammettere che Gesù non ha certo posseduto la dote della saggezza cosi come la intendiamo noi: egli infatti non si e mai preoccupato di mediare evitando di esprimere in modo diretto le sue critiche nei confronti degli scribi, dei farisei, dei sommi sacerdoti, con la conseguenza inevitabile che ha scatenato verso di se il loro risentimento e il loro odio. Non si è preoccupato di conseguire un bene generale che comprendesse anche il suo bene.
Anche Giovanni il battezzatore era stato poco saggio: la convivente del re Erode era la moglie del fratello di questi e Giovanni, accusandola apertamente, aveva suscitato in lei un odio profondo che alla fine e stato la causa della sua morte.
Cerchiamo di comprendere, per quanto ci e possibile, il mistero di un comportamento che, in base ai nostri parametri umani, appare decisamente autolesionista. Mettere a fuoco l’errore, il comportamento sbagliato dell’altro, provoca come reazione un sentimento di odio. Se nel cuore di chi dirige il proprio dito accusatore contro l’altro non c’è condanna, ma vero amore, desiderio autentico e profondo di aiutare l’altro, l’abbandonarsi a quelle fauci assetate di sangue significa offrire se stesso come espiazione di quello e di tutto il male che sempre e ovunque si manifesta. Dunque perché ci sia espiazione occorre che il sangue versato sia puro e innocente.
Quello che sul piano di una logica umana appare incomprensibile diventa pertanto chiaro su un piano spirituale: il bene e il male sono indissolubilmente uniti come i due piatti di una bilancia al punto che, se manca uno dei due piatti, la bilancia non esiste più. Così sono il bene e il male nella vita di ciascuno di noi. Così e il bene e il male nella grande Vita che è l’unione, nello Spirito, delle nostre piccole vite. Gesù, offrendo se stesso, si mette su un piatto della bilancia e dona la possibilità, a chi accoglie riconoscente il suo sacrificio, di mettere in equilibrio, nella sua vita, i due piatti della bilancia. E’ questo un dono offerto non a un solo uomo, ma a tutti gli uomini e all’umanità tutta.
Annamaria Tallarico
Nessun tag per questo post.