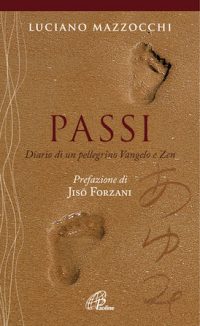«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate liniquità!”. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia».
* Dire, fare, essere
Nessuna pagina del Vangelo è così forte come questa nei confronti della nostra tendenza a far consistere la religione in parole e forme, siano esse preghiere, dogmi, riti, miracoli, esorcismi, regole, tradizioni. Non è in discussione la bontà di queste cose, ma la nostra magica presunzione che pretende di sostituire la vera religiosità con queste cose, l’essere uomo religioso con l’appartenenza all’istituzione religiosa.
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Queste parole di esordio provano l’onestà di fondo di Gesù come maestro religioso: egli non cerca l’attaccamento dei discepoli a sé come maestro, ma la loro adesione alla volontà del Padre. Anzi rifiuta l’abuso che il discepolo fa dell’invocazione del suo nome: Signore, Signore, e lo riporta al bivio decisivo della conversione alla volontà del Padre. Anche Shakyamuni, il Budda, ha rigettato ogni attaccamento dei discepoli alla sua persona, indicando che la via da percorrere è di ciascuno e mai deve essere scaricata sul maestro. Gesù disdegnò l’appellativo di «Maestro buono» con cui il giovane ricco gli si era rivolto per chiedere cosa dovesse fare per entrare nella vita eterna: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo» (Mc 10,18). In quell’aggettivo, buono, era infiltrata la presunzione del giovane di tirare dalla sua parte il maestro, forte in vista di riceverne un’alta considerazione. Gesù è tremendo ogni qual volta lo si vuole imbrigliare nei nostri tornaconti, fossero anche di natura spirituale o ecclesiale. Non esiste alcun passaggio privato, diplomatico, con raccomandazione, per raggiungerlo; l’unica via è quella del portone d’ingresso: la libertà consapevole dell’uomo che si converte e la gratuità dell’amore di Dio che non fa differenze. «Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore… Io sono la porta» (Gv 10,1-9).
Il Vangelo di oggi senz’altro diminuisce il peso che noi siam soliti attribuire all’istituzione ecclesiastica, intesa come l’organizzazione che dispone delle parole e dei riti cristiani, e ci converte alla vera comprensione della Chiesa come «sacramento o segno o strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG 1). La Chiesa non è tanto là dove fanno la loro comparsa le manifestazioni ecclesiastiche ufficiali, ma in chiunque vive nella vita quotidiana l’intima unione con Dio, sacramento dell’intima unità del genere umano. «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sulla roccia». Le fondamenta di una casa affondano nella terra e non sono visibili. Tutto ciò che della casa è visibile non sono le fondamenta, ma la parte che sorge sulla fondamenta. Così è della Chiesa: tutto ciò che è visibile: riti, dogmi, preghiere, iniziative ecc. corrisponde alla parte della casa che emerge: muri, porta, finestre, camere, balconi ecc., che continuamente noi usiamo.
Le fondamenta sono quella parte che non è visibile e che non può e non deve divenire visibile. Fondamenta scoperte alla luce del sole non sono più fondamenta. La Chiesa deve essere consapevole che tutta la parte visibile di se stessa poggia su un fondamento invisibile, che deve rimanere tale, di cui la Chiesa non deve né parlare, né far mostra. Se lo facesse, non sarebbe più il fondamento. La Chiesa deve poggiare sul silenzioso radicamento in Dio e lo deve coltivare colla pratica del silenzio. I tre anni di vita pubblica di Gesù poggiavano sui trent’anni di silenzio, di lavoro manuale, di vita familiare di Nazaret. Quanto ci facciamo fotografare nelle nostre liturgie, nei nostri viaggi apostolici! Quanto chiacchieriamo attorno alle nostre prodezze missionarie!
Se comprendiamo tiene, sappiamo che il sacro poggia sul profano, il rito sulla vita, l’appartenenza religiosa sull’appartenenza al creato, l’essere cristiano sull’essere uomo, l’essere uomo sul semplice esistere. Tutto a manifestazione di qualcosa più grande da cui sgorga; tutto quindi deve essere offerto di nuovo al tutto da cui lo riceviamo. La vocazione della Chiesa è, lo diciamo sempre, il servizio: il servizio di ricevere e il servizio di offrire. Se non esala nessun fumo di tornaconto e di vanagloria, allora il suo servizio è luminoso: il silenzio è la luce che fuoriesce dalla parola e la parola è il calore che emana dal silenzio!
p.Luciano

* Zelo amaro
A un certo punto della regola di san Benedetto si trova un’indicazione sorprendente: Zelum non habere – Non essere zelante. Come, diremmo, non bisogna consumarsi nello zelo? Non è forse lo zelo il segno della buona volontà, della totale dedizione?
Avevo da poco iniziato a fare zazen sotto la guida di un caro amico e maestro, che si chiamava François Viallet e aveva allora circa settant’anni, quando mi recai a stare da lui per un breve periodo di quindici giorni. Mi buttavo a capofitto nella pratica, nonostante la fatica e la pressoché totale incomprensione. Mi sentivo del tutto devoto al maestro e alla via. Un giorno vennero a trovarci alcune persone, lui mi presentò e, con la sua pronuncia francese disse di me, guardandomi: «E’ molto nello ze… lo Zen!». Sono passati più di venti anni. Non dimentico quello sguardo ridente, quella pausa e quella è strascicata che per un attimo mi fece credere che stesse dicendo di me che ero molto nello Zen! Quello Zen diventato zelo, mi ha detto, su di me e sul mio atteggiamento, più di mille spiegazioni. E molto più impegnativo e totalmente coinvolgente essere se stessi che far finta, magari a prezzi di sforzi sovrumani, di essere diversi e migliori di quello che siamo. Finché c’è spazio per guardarsi essere siamo nello zelo, che è tanto più amaro quanto più pensiamo di star facendo chissà che cosa, magari nella speranza che ce ne sia accreditato il merito.
Nell’agiografia buddista c’è un esempio illuminante di quello zelo che è la quintessenza del costruire sulla sabbia. Uno dei assidui discepoli di Sakyamuni Budda, suo cugino Devadatta, è la figura che rappresenta it tradimento così come Giuda lo incarna nel cristianesimo. Questo Devadatta era così zelante da imitare ogni atto di Budda. Invano il maestro lo rimproverava: «Non devi imitare me, devi cercare il vero modo di essere te stesso!». A forza di imitare il maestro, Devadatta si convinse di essere migliore di lui, di essere più buddista di Budda: e tramò per eliminarlo, pensando che non fosse più all’altezza della situazione. Devadatta appariva senz’altro come il migliore dei discepoli di Budda: in realtà non aveva compreso neppure l’orientamento della via che Budda indicava. Il vero tradimento, quello per cui possiamo sentirci dire: «Non vi ho mai conosciuti», è il tradimento che operiamo verso noi stessi. Quando invece di cercare di esprimere il modo autentico di essere quello che siamo, ci ammantiamo di vesti prese a prestito, magari lacere e sporche per far vedere come siamo umili e poveri. Il regale manto del povero è il suo essere così come è: oltre a questo, anche una veste di tela di sacco può essere lo schermo su cui proiettare l’ombra della mia vanità.
Jiso

* Lo spirito è un vento libero e creativo
Nella storia dell’arte, della letteratura, della musica, di tutte le scienze umane in generale i grandi movimenti (pensiamo all’illuminismo, al neoclassicismo, al romanticismo, ecc.) presentano significative analogie: in primo luogo hanno un preciso rapporto col periodo storico durante il quale si sviluppano, di cui sono a un tempo espressione ed emanazione; in secondo luogo hanno grandi iniziatori: si tratta di personalità che, pur formate attraverso studi tradizionali, non rientrano negli schemi, non seguono pedissequamente le regole da tutti accettate, avvertendo dentro di sé quel vento di novità che comincia a sentirsi nell’aria e che forse nessuno ancora percepisce. Essi dunque, irrequieti, insofferenti di fronte a verità precostituite, forse messi da parte e criticati, inseguono quel vento che annuncia l’arrivo di una nuova stagione e le loro opere esprimono il nuovo che faticosamente avanza. Infine il nuovo si afferma esprimendo il massimo della sua bellezza.
Ma il culmine rappresenta anche l’inizio della decadenza: viene infatti codificato in regole, quasi a volerlo trattenere, ignorando che il tempo passa e che anche il nuovo è destinato, naturalmente e necessariamente, a invecchiare. Ecco allora che si forma una nutrita schiera di imitatori dei primi, grandi iniziatori, ma le loro opere col passare del tempo diventano sempre più vuote, sterili, ripetitive. Manca infatti quella forte carica interiore, quello slancio, quella consapevolezza che, sole, ne garantiscono l’autenticità.
La parola del Vangelo è simile a quel vento di novità, refrattario a ogni regola precostituita, che abbiamo visto essere alla base di tutti i grandi movimenti artistici e letterari. E la voce dello Spirito che tocca in profondità il cuore e stimola comportamenti innovatori. Noi dobbiamo certo formarci a quanto codificato e stabilito dalla tradizione; anche l’entrare in contatto con personalità di elevata spiritualità direttamente o attraverso letture è senz’altro positivo ed edificante. Ma, come i grandi artisti ci insegnano, non dobbiamo scadere a diventare semplici imitatori, semplici esecutori di direttive che sono imposte dall’alto.
Gesù è molto esplicito: ci dice, senza mezzi termini, che non basta dire Signore, Signore, né profetare, né addirittura compiere miracoli o scacciare demoni, ma fare la volontà del Padre. Ma qual’è la volontà del Padre? Che cosa vuole il Padre da ciascuno di noi? Non possiamo saperlo: nessun teologo può dircelo perché la nostra piccola mente umana non può comprendere la grande mente di Dio.
La volontà del Padre è manifestata dallo Spirito la cui voce noi possiamo solo intuire e dal quale possiamo farci guidare solo se siamo disposti a rinunciare alla vana pretesa di conoscerla per certo e in anticipo.
Annamaria Tallarico