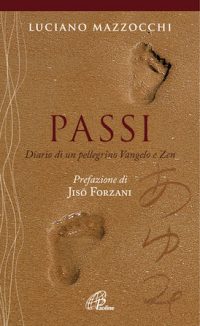In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
* Il terzo figlio che noi vorremmo avere
Perché non c’è il terzo figlio che al comando del Padre di andare a lavorare nella vigna risponda di sì e subito mantenga la promessa fatta? Noi tutti vorremmo essere quel terzo figlio; tutti i genitori vorrebbero avere figli come lui e tutti i sacerdoti vorrebbero che i loro parrocchiani appartenessero alla sua categoria. Ma nella parabola di Cristo quel terzo figlio non c’è.
Il terzo figlio che dice di sì ed esegue subito quello che ha promesso ci attira al punto che anche da adulti maturi, oppure anche da anziani, non ci siamo ancora conciliati con la nostra realtà così com’è. Continuiamo a rimpiangere l’innocenza perduta e a odiare la vita che ce l’ha portata via. Ce la prendiamo con gli altri, perché ci hanno influenzato con il loro cattivo esempio, o con gli avvenimenti che ci furono avversi. Soprattutto siamo scontenti verso noi stessi perché constatiamo, dopo tutto, di non essere differenti dagli altri in debolezza e fragilità. Avremmo voluto coronare il nostro pellegrinaggio terreno senza perdere l’innocenza primordiale. Se abbiamo il coraggio di indagare in radice questo nostro atteggiamento, ci accorgiamo che la mira nascosta per cui vorremmo essere quel terzo figlio è il nostro autocompiacimento. Vorremmo noi stessi poter far festa alla nostra santità, naturalmente mettendo in rilievo di essere migliori degli altri, poveri peccatori. Nella sua parabola Cristo non conosce questo terzo figlio. Né il Padre l’ha creato né lo Spirito Santo lo irrora di pioggia primaverile.
«Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò». II primo figlio è la categoria del sì a parole e del no a fatti. Sono gli incoerenti e gli irresponsabili; ma sono anche gli idealisti e i presuntuosi. Questi dicono sì ad alto livello, mirando piuttosto alla loro autorealizzazione. Quel sì, che sembra generosità e che invece si rivela inganno, nasce probabilmente dal fatto che uno già prefigura per sé la meta, come coloro che fanno un cammino religioso per costruire loro carattere e adornarsi di virtù a loro utili per fare guadagni nella vita. E anche il sì che una istituzione religiosa può innescare quando, già in partenza, si ripropone di raggiungere certi effetti sociali e politici. Sembra un sì detto a Dio, invece è detto a se stessi. Quindi è destinato a non portare frutto, perché nel terreno manca l’humus dell’umiltà.
«Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò». E l’esempio di questo secondo figlio che viene additato dal Vangelo come la via da percorrere. E la via del no che diventa sì; forse è la via di un ripetersi di no che diventano sì. Come mai la strada non è tutta diritta, ma si snoda tra tante curve, al punto tale che spesso sembra di fare ritorno indietro?
Ci pare una domanda dalla difficile risposta, o comunque dalla risposta complessa. Eppure se a una mamma fosse proposto di avere dei figli che non fanno mai i capricci, che non piangono mai, che non sporcano mai, in altre parole dei figli che conservano l’innocenza originale intatta e non necessitano delle cure educative dei genitori, quella mamma rifiuterebbe. E infinitamente più vitale avere figli che dicano di sì, e poi di no, e poi ancora di sì, fino al giorno in cui la via tutta a curve non sbuchi in una pianura dagli ampi orizzonti. E meglio, perché così genitori e figli crescono assieme, scoprono assieme, piangono e ridono assieme. Senza la fatica del camminare, e senza l’attenzione del verificare continuamente la direzione o di correggerla quando è sbagliata, non si fa l’esperienza della via e non nasce la consapevolezza della via.
Qualora all’uomo fosse possibile discutere con Dio sulla creazione, l’uomo che si blocca nel sì facile, detto con le labbra e non coi fatti, chiederebbe a Dio di essere un creatore migliore e di crearci in modo tale che nella vita ci sia meno da tribolare. Invece l’uomo che nella fede converte il no della sua negatività nel sì reale della vita concreta, chiederebbe a se stesso di essere una creatura migliore e a Dio direbbe soltanto: Grazie! Il secondo figlio non sperpera la vita inseguendo chimere di santità irreali, oppure rimpiangendo l’innocenza originale perduta per sempre; convertendo il no dei suoi errori nel sì della fede operosa, lavora realmente nella vigna del Signore, a cui offre perfino i propri difetti e peccati.
«In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio». Cristo aveva l’ardire di pronunciare queste severe parole di fronte ai principi dei sacerdoti del tempio di Gerusalemme, rappresentanti di tutti i sacerdoti di tutte le religioni. In quei sacerdoti siamo prefigurati anche noi, ciascuno di noi, con la sua tendenza a giustificarsi con abili ragionamenti e astute parole. E sempre possibile confondere il cammino religioso con atteggiamenti di falsa umiltà.
«Voi, pur avendo visto…, non vi siete nemmeno pentiti». E’ possibile vedere e non pentirsi. E possibile compiere le pratiche spirituali le più sante, come l’eucaristia e lo zazen, ed essere vacui, senza che avvenga alcun rinnovamento. In tali situazioni è grazia se l’uomo cade in qualche peccato eclatante che smascheri la sua ambiguità e così, venuto allo scoperto, cominci il cammino della conversione. E molto più vicino al regno di Dio un peccatore vero, che un santo falso.
p.Luciano

* Conflitto
Questa parabola dei due figli a una di quelle che più mi danno da pensare. Sarà perché mi riconosco per carattere nel primo figlio e per condizione esistenziale nel secondo, ma non riesco a vederli come due: mi sembra di essere un po’ uno e un po’ l’altro. Inoltre mi pare che manchino altri due figli: quello che dice sì e va, e quello che dice no e neppure va. Dobbiamo pensare che questi due non facciano parte degli eredi della vigna. Che quello che dice no e non va sia fuori, è facile da capire: rifiuta completamente ogni partecipazione e si auto esclude. Meno facile capire perché non è nominato un ipotetico figlio che dice sì e coerentemente va. Ma se riflettiamo, questo figlio non è un vero figlio, perché non ha bisogno di un padre, di chi lo educhi. Ha già capito tutto da solo, è perfettino così. Un figlio figlio per un padre; un padre è padre per un figlio. La funzione di padre non si esaurisce nell’atto del generare: c’è poi un rapporto da educatore a educando in cui i due attori del rapporto sono complementari e necessari l’uno all’altro. Se viene a mancare la necessità di uno dei due elementi, il padre, in quel momento anche l’altro scompare: quel figlio ipotetico non esiste come figlio, per questo non è nominato.
Vorrei fare a questo punto un piccolo inciso. Nelle parabole si parla sempre di padre, e non di madre: una spiegazione del perché ci vuole. A parte le considerazioni culturali e storiche, per cui ai tempi e nei luoghi di Gesù il rapporto di discendenza era incentrato sul rapporto padre-figlio, io credo che, da un lato, si intenda comprendere nella parola padre anche la madre: cioè che padre dica tutto complesso delle figure dei genitori e allevatori dei figli. D’altro lato credo ci sia una differenza fra ciò che rappresenta la figura del padre e quella della madre che l’uso del termine padre vuole sottolineare, qui e in altre occasioni del testo evangelico. La maternità è una funzione che stabilisce un legame fisico fra madre e figlio: è la trasmissione della vita nel senso più diretto, la vita che è tutta racchiusa in quel passaggio di vita. Il legame della paternità a molto meno corporale , più immateriale: è un po’ come il passaggio della vita intesa come scintilla universale, la vita che accende altra vita. La paternità insomma più impersonale della maternità, e quindi il termine padre è più adatto del termine madre per esempi di carattere metaforico.
Per tornare al testo, nei due figli che,Gesù racconta, è presente un conflitto: con se stessi e con il padre. E presente un conflitto: per questo essi sono reali. Il rapporto che tanto il primo che il secondo figlio hanno con il padre, con la vigna, con se stessi, con il proprio modo di essere e di fare è reale proprio perché segnato dal conflitto. Senza polo negativo e polo positivo a contatto non si accende nessuna luce. Certo, Gesù ci dice che il secondo figlio, quello che risolve conflitto andando nella vigna precede il primo figlio in cui invece conflitto si risolve nel non andare. Però Gesù non dice che il secondo figlio non entrerà: dice che sarà preceduto dall’altro.
«Sono venuto a portare la guerra, non la pace». Gesù afferma che senza conflitto non c’è crescita: senza conflitto la via non diviene carne e ossa e sangue, resta una questione intellettuale. Perché penetri nel corpo, perché la via si faccia corpo, è necessario il conflitto. La colpa del primo figlio, infatti, è di lasciare il confitto allo stato latente , di non prenderne atto. In un testo di cui non ricordo la collocazione e che cito a memoria Dōghen dice:
Fra una persona che si entusiasma per la pratica e per la via e si butta a capofitto inizialmente, anche perché convinto da quanto sente dire, e una persona che pratica magari controvoglia ma che sa cosa sta facendo, sa che la pratica e necessaria, piaccia o non piaccia, e motto probabile che il primo a un certo punto si deluda e smetta e secondo invece continui fino alla fine.
Chi si butta nella pratica religiosa perché deluso dal mondo, perché si sente inadeguato ai compiti del mondo, perché vuole sfuggire al mondo, dirà subito sì volentieri a chi gli indica la via, ma è probabile che perda entusiasmo quando si rende conto che andare nella vigna non vuol dire eludere i problemi. Chi invece sa di essere attaccato al mondo, ai suoi piaceri, al suo fascino, ma sa anche, proprio perché ci si è calato dentro, quanto ingannevole e inconsistente sia mondo, anche se non ha voglia si rende conto che cercare la via è necessario. Necessario, ma non indolore: bisogna rinunciare a tante cose. Chi rinuncia a cuor leggero non ama davvero le cose a cui rinuncia. Chi non ama le cose a cui rinuncia, che sono le cose che ha sotto gli occhi, la cose che hanno a che fare con la sua vita di ogni giorno, sarà capace di amare davvero le cose che non si vedono, e che non danno soddisfazione? La prostituta, il pubblicano, sono l’esempio di chi ama il mondo, i suoi piaceri, con il corpo: sarà anche un modo di amare egoista e impuro, una forma di amore che si chiama in gergo religioso attaccamento, ma a pur sempre amore. Un amore del genere brucia e fa male, spesso fa fare il male: ma pilò innescare il conflitto che genera il pentimento, senza il quale la conversione non è possibile. L’amore intellettuale del primo figlio è asettico, meno coinvolgente: per questo si spegne facilmente.
Direi che è una questione di spessore, di profondità: il secondo figlio prima disubbidisce, non accetta il comando paterno, fa di testa sua: poi capisce e va. Va perché ha capito sulla sua pelle e con la sua testa di dover andare. Il primo figlio dice subito sì, per essere ubbidiente: ma poi non va perché l’ubbidienza che è solo assenso è tiepida, non nasce dall’esperienza e dalla convinzione.
«Conosco le tue opere: tu non sei ne freddo ne caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: “Sono ricco, mi so- no arricchito; non ho bisogno di nulla”, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista. lo tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo» (Apocalisse 3,15-19).
Jiso

* Il segretodel cammino in un piccolo passo
I genitori hanno alle volte la sensazione di parlare invano ai loro figli. Questi sembrano sul momento accogliere consigli e insegnamenti, ma alla fine, quando si passa dalle parole ai fatti, tali insegnamenti risultano dimenticati, se non addirittura volutamente ignorati. La sensazione per i genitori è allora quella di versare acqua in una buca di sabbia, ossia di fare una cosa assolutamente inutile. Quanto più l’insegnamento a orientato a suscitare nel figlio cambiamenti, tanto più difficilmente attecchisce. Ma il genitore non può rinunciare a intervenire, consigliare, guidare, anche quando ciò sembra inefficace; non può non fare tutto quanto è nelle sue possibilità per far sì che la piantina, di cui è responsabile, cresca bene.
Che cosa potrebbe indurre il figlio ad accogliere veramente e a far suo quell’insegnamento? Che cosa potrebbe rendere quell’insegnamento stimolo, per il figlio, a un rinnovamento interiore, a un miglioramento nei rapporti con se stesso e con gli altri? Le condizioni necessarie affinché questo avvenga sono molteplici. Innanzitutto occorre che vi sia una solida base di stima e di affetto reciproco, inoltre che l’insegnamento miri effettivamente al bene del figlio: molte volte infatti noi genitori spacciamo per bene del figlio quello che è, in realtà, un nostro bisogno di sentirci gratificati o valorizzati attraverso di lui, come ad esempio avviene quando pretendiamo che primeggi a tutti i costi in attività scolastiche o sportive.
Ma questi due fattori non sono sufficienti. Il figlio infatti potrebbe sforzarsi di mettere in pratica consigli e insegnamenti più per compiacere il genitore che ama che per intima convinzione. Condizione indispensabile affinché l’insegnamento sia produttivo è che sia in atto, nel ragazzo stesso, un processo di crescita, un desiderio di rinnovamento, suscitato non solo dalle parole del genitore, ma anche dalla propria esperienza, dalla personale riflessione, dalla sofferenza. Avviene allora che, come i lati obliqui di un triangolo finiscono con l’incontrarsi nel vertice, così genitore e figlio si dirigono verso il medesimo punto e l’insegnamento non è avvertito come qualcosa di estraneo, di imposto, ma esprime veramente ciò di cui il figlio ha bisogno.
Nella parabola riferita dall’evangelista Matteo, il figlio, che in un primo momento si era rifiutato di obbedire al padre, alla fine si pente e decide di ascoltarlo. Quel pentimento è prezioso; in quel pentimento c’è tutto il travaglio interiore, la crisi, la crescita del figlio.
Nel cammino spirituale ciò che conta non è il punto di partenza, ma quel passo che permette di andare oltre. In questa ottica i pubblicani e le prostitute nel regno di Dio passano avanti ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo proprio perché, a differenza di questi ultimi, grazie a un travaglio interiore fatto di sofferenza e pentimento, sono stati in grado di realizzare un cambiamento, un’evoluzione: hanno fatto quel passo necessario per procedere oltre.
Annamaria Tallarico
Nessun tag per questo post.