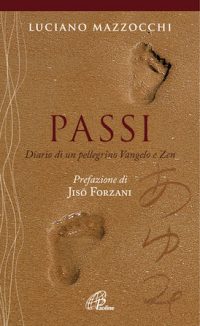In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
* La pietra scartata
La parabola dei vignaioli infedeli è un Vangelo molto severo, uno dei più severi pronunciato da Cristo, il maestro dell’amore. Vangelo severo che diventa dolce soltanto accogliendolo senza interpretazioni riduttive.
«Quando fu il tempo dei frutti». L’agricoltore della parabola è Dio, la vigna è la nostra vita, i vignaioli siamo noi. Dopo anni e anni di cure per coltivare la vigna e proteggerla da tutto ciò che la può nuocere, finalmente i primi frutti. La parabola insegna che la vita ci è data come un bene che porta frutti, perché questa è la sua natura.
L’albero nel suo sviluppo ha lo stadio in cui la sua esistenza è tutta rinchiusa in un seme; poi si dischiude in virgulto che cresce. Raggiunta la sua statura definitiva, l’albero ogni anno rimette in atto il suo vigore adolescenziale rivestendosi di foglie nuove, poi quello giovanile con la fioritura e infine quello adulto maturando i suoi frutti. Questi all’inizio sono piccoli e acerbi; ma, come l’albero madre, anche il frutto cresce e raggiunge la sua maturità fatta di sapore, profumo, colore. A questo punto l’albero cede i suoi frutti all’uomo e agli altri esseri viventi, affinché se ne nutrano a beneficio della vita universale. In genere, quando l’albero matura i suoi frutti perde le foglie che lo ornavano e assume un aspetto molto dimesso e umile. Basti ricordare l’aspetto della vite o dell’albero di cachi. Le foglie hanno raggiunto un colore rosso-giallo intenso, il grado massimo della loro bellezza e quindi, danzando nel vento, cadono a terra come un manto di festa. Sui rami restano solo i frutti a raccogliere tutti i raggi dell’ultimo sole d’autunno e così perfezionare la dolcezza della propria polpa. E una grande legge della natura che quando un vivente porta il suo frutto sospenda tutte le altre sue attività e riversi le sue energie solo nel portare frutto. Così è la donna quando partorisce. I cereali devono letteralmente seccare e morire per dare i chicchi. Portare frutto significa sempre sforzo intenso, umiltà profonda, offerta gratuita e totale di se stesso. Comporta la disponibilità a morire. Portare frutto non è quindi un’attività redditizia nella categoria dell’efficienza; a invece un’attività profondamente religiosa in cui la via del frutto coincide con quella dell’offrire se stesso. Manifesta la natura divina della nostra origine che ci fa assomigliare a Dio. Per questo Dio, colui che ci ha trasmesso la natura divina che porta frutti, viene a chiederci il raccolto.
«Ma quei vignaioli… dissero tra sé: Costui e l’erede; venite, uccidiamolo, e avremo noi l’eredità». Uccidere il Figlio che viene a chiedere il raccolto a nome del Padre non significa uccidere Dio, ma la vita; uccidere l’ordine universale. I vignaioli siamo noi, quando invece di portare frutti e restituirli a Dio, ci attacchiamo ai doni naturali ricevuti e facciamo della vita un calcolo e un mercato. Ci attacchiamo alla bellezza e al vigore del corpo, ai titoli di studio perseguiti dalla mente, alla quiete interiore raggiunta nei ritiri spirituali, ai guadagni del nostro lavoro. Facciamo da padroni sulla vita e miriamo a eccellere sugli altri. Un proverbio orientale dice così: Quando le spighe di riso del campo hanno abbassato la testa per il peso dei chicchi, la spiga che resta diritta e che si fa vedere sulle altre è quella vuota.
Nella vita accadono delle situazioni che sono come i servi mandati dal padrone a riscuotere il raccolto. Possono essere trasferimenti, malattie, separazioni, partenza di un figlio che si sposa e infine, soprattutto, la morte. Sono avvenimenti che sovvertono il nostro quieto vivere e mettono allo scoperto se la nostra vita è feconda o sterile. Se viviamo una vita sterile ripiegata su noi stessi, quel Figlio che viene a chiederci il raccolto diventa il nostro nemico. L’attaccamento alle cose ci impedisce di maturare i nostri frutti, perché maturarli significa cederli. Diciamo di no alla vocazione di maturare col passare degli anni. Chi non sa invecchiare non è religioso e, forse senza accorgersene, trama di uccidere il Figlio che gli viene incontro nella pasqua, nel passaggio del tempo.
«La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’ angolo; Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo fara fruttificare» Trattenere la vita, attaccarsi a essa e cercare di E bloccarla, anziché viverla nell’operosa attesa del regno! la tentazione narcisistica, è la via della tristezza. Né si ama, né si a amati; perché non ci si dona. Case ricolme di cose e cose: mobili, quadri, cani e gatti; ma assenza di bambini. Se c’è un bambino, è un possesso.
Nelle religioni la tentazione dei vignaioli è il proselitismo. Cristo, dopo tre anni di indefesso annuncio del Vangelo, morì abbandonato anche dai fedelissimi. Fallimento o raccolto genuino? E tutto partì da lì.
p.Luciano

* La proprietà dei frutti
La parabola dei vignaioli omicidi non è una parabola cristiana. Nel senso che non è una parabola specificatamente cristiana, ma una parabola religiosa in generale; anzi, a una parabola sulla religione. Se riusciamo a comprenderla veramente, non solo in termini intellettuali ma facendola nostra come criterio di comportamento, incarnandola, allora religione non è più un concetto astratto ma coincide con il nostro modo d’essere: e non vi a più bisogno di parlare di religione.
Il problema che la parabola ci sottopone a uno solo: non confondere i vignaioli con il padrone della vigna. La colpa dei vignaioli una sola: comportarsi come se fossero i padroni della vigna. Non è un problema semplice, né tanto meno teorico o teologico: è un problema esistenziale. Il fatto è che il padrone, dopo aver piantato la vigna, averla circondata di una siepe protettiva e fornita del necessario, la affida ai vignaioli e se ne va. Li lascia soli. E qui comincia delirio di potenza dei vignaioli. Qui comincia il delirio della religione. Ogni integralismo, ogni visione chiusa, ogni sistema religioso inteso come steccato e barriera che racchiude la verità, ha il suo fondamento in un atteggiamento di fondo identico a quello dei vignaioli. Dimentichi di essere né più e né meno che dei custodi di qualcosa che non è di nessuno, si appropriano della vigna come fosse roba Toro. Che lo facciano per eccesso di zelo o in malafede, poco cambia: il risultato a che si sentono esclusivi fruitori della vigna. Quella siepe protettiva, che doveva servire a delimitare un ambito all’interno del quale far fruttare la vigna per il bene del padrone, diventa un muro di cinta che serve a escludere chi sta fuori, chiunque esso sia. Così, quando vengono altri servi dello stesso padrone a ritirare il raccolto vengono ricevuti come nemici. Si fa strada nei vignaioli un pensiero: spettano a noi i frutti della vigna. Noi l’abbiamo coltivata, protetta, accudita: abbiamo diritto ai frutti.
Credo che la mentalità occidentale sia particolarmente accanita in questo accampare diritti anche in campo religioso. Una certa religiosità del premio, che promette il godimento dei frutti della vigna in relazione all’appartenenza a una specifica fede religiosa, ha in sé il germe della degenerazione dei vignaioli, che la parabola denuncia. I vignaioli invece, non devono far altro che coltivare la vigna e consegnare i frutti a suo tempo. Essere vignaioli a già premio: che altro vuole ancora? Che mentalità utilitaristica è mai quella che accampa diritti sul frutto della vigna?
Fuori di metafora, noi non siamo i proprietari della nostra vita. Essere vivi è già un premio straordinario: vivere in spirito di liberty e saggezza, e trasferire i frutti a chi viene dopo, ecco il compito di noi vignaioli. Così la vigna della vita prospera e sono accolti con gioia tutti gli inviati che vengono a prendere il raccolto. Non c’è niente da guadagnare all’infuori di questo. Non aver niente da guadagnare: ci pub essere premio più grande? Un detto africano suggerisce: Noi non lasciamo la terra in eredità alla generazione successiva: noi l’abbiamo ricevuta in prestito da lei.
I costruttori hanno scartato la pietra che pareva loro inutile al bisogno: ed ecco, la pietra inutile era quella angolare. Finché non ci si rende conto che la religione non serve a nulla, non diventerà mai vero servizio. In questa valorizzazione dell’inutile, la religiosità orientale ci a indubbiamente maestra. A parte le degenerazioni che finalizzano tutto al raggiungimento di stati spirituali, di illuminazioni intese come conquiste personali, lo spirito insito nella via è proprio quello che essa non serve a nient’altro che al percorso stesso. La via è la vigna: nessun viandante serio pensa di essere il padrone della via. Un vero viandante ama camminare: non cammina per arrivare in un posto a godersi il riposo dal cammino, cammina perché è fatto così, è un viandante, e per tenere aperta la via.
Come ricordo
voglio lasciare
i fiori della primavera,
il canto del cuculo d’estate,
i colori dell’autunno.Ryōkan
Jiso

* Accendere una piccola luce, gettare un piccolo seme
Nel presentare ai ragazzi di scuola media un argomento quale la rivoluzione industriale, le cui conseguenze vanno a modificare sostanzialmente l’economia degli stati in cui si diffonde, i modi di vita, la stessa struttura delle città, non si pub non prendere in esame, fra i vari aspetti, la diversità del lavoro dell’artigiano rispetto a quello dell’operaio dell’industria. Il primo, si a soliti osservare, segue il lavoro in tutte le sue fasi; decide se, come e quando usare eventualmente strumenti tecnici e alla fine percepisce con soddisfazione che quel prodotto, che a riuscito a realizzare, è frutto del suo lavoro, del suo impegno, delle sue capacita: è dunque qualcosa che gli appartiene, che pub a suo piacimento tenere per sé o vendere ricavando un meritato guadagno. L’operaio dell’industria invece è costretto a seguire i ritmi delle macchine; non segue tutte le fasi di lavorazione essendo il suo lavoro specializzato, cioè limitato solo ad alcuni compiti precisi e alla fine non pub dire con soddisfazione: «Questo l’ho fatto io!», né pub ritenere di sua proprietà il prodotto realizzato.
Noi giustamente giudichiamo positivamente il lavoro dell’artigiano, più umano e gratificante, mentre consideriamo alienante e ripetitivo quello dell’operaio. E naturale per tutti noi ritenere che quanto facciamo debba avere un chiaro riscontro, se non in termini di denaro, almeno in termini di soddisfazione. E raro agire in modo totalmente disinteressato. Anche se generosamente, in certe occasioni, non pretendiamo alcun risarcimento per quanto facciamo, rimane forse in noi un po’ di autocompiacimento e il ricordo di quanto ci siamo prodigati.
Alla luce di queste considerazioni i vignaioli della parabola che ci viene presentata questa domenica tutto sommato esprimono un modo di intendere sempre attuale che, per certi aspetti, ci appare anche legittimo. Essi si impegnano non risparmiando fatica e lavoro e alla fine ottengono frutti abbondanti. Perché dovrebbero privarsene consegnandoli al padrone? L’insegnamento che la parabola vuole offrirci è che dobbiamo andare oltre questa mentalità, che dobbiamo considerare il frutto del nostro lavoro come qualcosa che non ci appartiene.
Anche la natura in effetti, nel suo continuo rinnovarsi, sembra fornirci un insegnamento analogo: se il fiore non offrisse il suo polline, se l’albero non offrisse i suoi frutti e quest non offrissero i semi, come si perpetuerebbe la vita? Lavorare, lavorare con cura perché frutto della nostra fatica sia Bello e succoso, poi offrirlo. Quel frutto è allora una piccola luce che si accende, un piccolo seme gettato 11. Chi sarà rischiarato da quella luce? Che cosa germoglierà da quel piccolo seme? Questo non ci deve interessare. Dimentichiamo allora quella piccola luce che abbiamo acceso e quel piccolo seme che abbiamo gettato e ricominciamo con gioia a lavorare affinché un’altra luce si accenda, un altro seme cada nel terreno.
Annamaria Tallarico
Nessun tag per questo post.